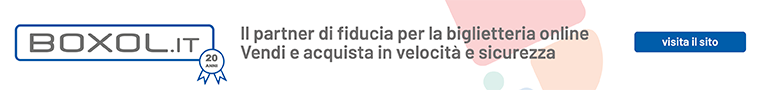Patrick Woodroffe
Il signore degli anelli.
 di Douglas Cole
di Douglas Cole
Spesso i soggetti di questa rubrica sono figure con delle storie molto lunghe nell’industria dello spettacolo, sono stati pionieri, hanno aiutato ad inventare un mestiere e possono condividere racconti d’altri tempi e illustrare come sia cambiato il lavoro negli anni. Spesso sono all’apice della loro professione a livello internazionale o anche solo italiano. Il personaggio con cui abbiamo fatto due chiacchiere questa volta è la “summa” di tutte queste caratteristiche.
Patrick Woodroofe è probabilmente il lighting designer per lo spettacolo musicale più conosciuto al mondo. Non ci dilunghiamo ad elencare tutti gli artisti e gli eventi per i quali questo signore ha progettato l’illuminazione: le pagine a disposizione non basterebbero e sono comunque meglio spese per i suoi racconti. Diciamo solo che il suo curriculum di lighting designer parte da metà anni ‘70 e via via aggiunge sempre più nomi di enorme impatto nella scena musicale, fino alle cerimonie delle Olimpiadi di Londra 2012. Tra i lighting designer che seguono sempre i tour di serie AAA, Woodroffe è quello con la carriera più composita e più longeva: quando Roy Bennett e Willie Williams hanno iniziato, e quando Baz Halpin era probabilmente ancora alle elementari, lui era già un veterano.
Woodroffe ci ha concesso una bella chiacchierata presso l’Arena 105 Stadium a Rimini in occasione della data zero dell’Inedito World Tour di Laura Pausini.
Nel tuo ruolo, pensi oggi di essere essenzialmente all’apice dell’industria?
Oggi sono probabilmente il miglior lighting designer a Rimini, non andrei oltre.
Guardando il tuo CV, pensavamo di trovarci davanti un signore un po’ più stagionato...
Pensavo di aver compiuto 58 anni adesso, ma mia moglie (che tiene il conto per me) mi ha informato recentemente che ne ho solo 57... è riuscita lei a darmi un anno in più da vivere.
Quali sono state le tue prime esperienze, il tuo background?
Mio padre era un militare e sono cresciuto a Singapore, in Germania e in tanti altri paesi. Penso che la voglia di viaggiare nasca da lì. Non sono particolarmente ben istruito; ho frequentato una buona scuola, ma ero molto pigro e ho fatto sempre il minimo. Però ho sempre pensato che sarei stato bravo a fare almeno una cosa, anche se non sapevo ancora cosa. Dentro questo lavoro ci sono un po’ caduto. Quando ho iniziato io, a metà anni Settanta, nel rock&roll non c’erano i lighting designer; c’erano i service luci, praticamente. In quell’epoca in Inghilterra c’erano solo un paio di aziende: non c’erano luci intelligenti, niente truss; era tutto molto semplice. Lavoravo per uno di questi service; giravo in un camion e aiutavo a montare le luci, anche per gruppi importanti come gli Osmond Brothers, i Queen, Maggie Bell, Golden Earring e altri intorno al ‘75. Poi ho cominciato a controllare le luci per un gruppo che si chiamava “The Heavy Metal Kids”.
La mia grande opportunità è arrivata quando sono andato a lavorare per Rod Stewart come tecnico – “roadie” ci chiamavano all’epoca – senza titoli o specializzazioni. Rod stava facendo la sua prima tournée da solo dopo aver lasciato The Faces. Tre giorni prima della partenza del tour licenziò il tizio che gli faceva le luci, poi si guardò intorno e disse “c’è qualcuno qui in grado di fare quello che faceva lui?” Alcuni degli altri indicarono me dicendo: “Quello lì, lui ha fatto delle luci”.
La mattina dopo ero il “Lighting Designer” di Rod Stewart. E non era una cosa da poco, perché lo spettacolo che stava per portare in giro era una produzione “vera”, cioè aveva un grande set bianco, sipari e fondali bianchi: nel mondo del rock era una cosa nuova. Ho passato quattro o cinque anni bellissimi girando il mondo due volte con Rod; due tour: ‘77 e ‘79.
Oggi la carriera di tanti lighting designer comincia come programmatore per un designer più vecchio poco a suo agio con la nuova tecnologia: che percorso avete fatto voi che non avevate una generazione precedente di rock lighting designer a cui fare riferimento? Tu essenzialmente hai fatto un salto da elettricista/tecnico luci a designer...
Non l’avevo mai guardata in questo modo. Io sono stato molto fortunato ad essere una delle persone coinvolte quando era tutto agli albori. Era incredibilmente primitivo il modo in cui facevamo le luci in quegli anni. La tecnologia ha cominciato a svilupparsi quando i gig (spettacolo-lavoro, ndr.) sono diventati più ricchi. Quando ho iniziato io, in Inghilterra i più grandi artisti del momento – Led Zeppelin e compagnia – suonavano a Earl’s Court, che all’epoca era la più grande venue indoor che ci fosse. Fino a quando gli Stones e altri non hanno cominciato a fare i tour in America alla fine degli anni ‘70, nessuno si sognava di suonare negli stadi, anche perché nessuno fino a quel punto aveva pensato di andare in tournée per far soldi. Spesso le tournée si facevano in perdita per promuovere la vendita dei dischi, che erano il fulcro del business. Poi all’improvviso tutti si sono resi conto che si potevano far soldi suonando nelle grosse venue, o nelle arene, ma, allo stesso tempo, hanno anche capito che, per poter chiedere quei soldi, era necessario offrire un vero spettacolo.
Dovete ricordare che anche un palchetto per la batteria era una novità all’epoca: uno dei primi drum riser fu usato in una tournée che feci con i Queen. Pian piano abbiamo cominciato a poter portare in giro dei truss, sono arrivati i fari che si muovevano, i sistemi di controllo che ricordavano le scene da soli...
È stato proprio l’arrivo della console dotata di memoria a cambiare il nostro mestiere: invece di fare il “roadie” e rielaborare le luci ogni sera, il designer poteva concepire e creare lo spettacolo in anticipo e qualcun’altro poteva riprodurlo ogni sera. Quindi potevamo chiedere soldi all’inizio dalla produzione e guadagnare in modo dignitoso, potevamo creare diversi spettacoli e non essere strettamente legati alla tournée, così potevamo anche seguire diversi progetti in contemporanea. Quando lavoravo con gli Earth, Wind&Fire o con gli ABBA, magari venivo pagato abbastanza bene, o almeno così mi sembrava, ma significava stare in tour per almeno un anno alla volta a non fare niente altro. All’improvviso, con lo spettacolo “memorizzabile”, si è materializzato un nuovo lavoro, questa meravigliosa carriera che avevo cercato per tutta la vita: potevo essere creativo e dipingere bellissimi “quadri”, potevo essere molto propositivo con le persone, lavorare con artisti e con la crew e con altri designer... e disponevo anche di un bellissimo modo di girare il mondo con questo circo magnifico.
Però l’arte del disegno delle luci nel teatro era già piuttosto consolidata da secoli. Hai preso qualche spunto o qualche conoscenza da quel mondo?
Non proprio. Anzi, veramente è stato il contrario. Quasi vent’anni fa, mentre stavo lavorando con degli artisti importantissimi – gli Stones, Tina Turner, Rod Stewart e altri – ho pensato: “Oddio, questa gente non durerà, ormai hanno 45 o 50 anni! Non possono durare per sempre...” Così ho pensato di cercare altri angoli per il mio lavoro.
All’epoca tutta la tecnologia veniva sviluppata per i rock show, perché noi nel rock riempivamo gli stadi e avevamo tanti soldi. E in più c’era (e c’è ancora) la mania che spingeva tutti a volere il proprio spettacolo più grande degli altri, così anche se comprare quei nuovi “testamobile” costava migliaia di dollari o noleggiarli costava centinaia di dollari alla settimana, tutti ne volevano comunque un’enorme quantità. È evidente che tutta la tecnologia disponibile ha cominciato a transitare anche in ambito teatrale e televisivo e all’improvviso gente come me aveva l’opportunità di spostarsi in quei settori, fin allora dominati da gente cresciuta nel mondo un po’ chiuso del teatro (balletto, opera, prosa, ecc.).
Così ti sei trovato ad insegnare agli “artisti veri” del teatro...
Non esageriamo, ma sicuramente sono riuscito a presentare le nuove tecnologie in quell’ambiente. Io sono sempre stato sicuro che c’era qualcosa di più interessante che far lampeggiare le luci a tempo con la musica, sapevo che ci poteva essere qualcosa di più. 
Così un portafoglio di clienti già pieno è cresciuto ancora di più?
Probabilmente la mia base di clienti è cresciuta per un altro motivo, quello per cui sono qui a Rimini oggi: mentre facevo i tour in Europa, ho fatto amicizia con tanti promoter, come David Zard qui in Italia, o Thomas Johannsen in Scandinavia, e tanti altri, che poi finivano per chiamarmi a lavorare con gli artisti che seguivano in ambito nazionale. Mentre tutti i miei colleghi inglesi correvano dietro al gruppo americano o inglese del momento, io avevo i miei clienti consolidati, e nei tempi di preparazione tra una tournée e l’altra andavo fuori a lavorare in tutto il mondo. Così facendo sono diventato amico anche di tanti artisti internazionali che poi mi richiamavano per il loro spettacolo successivo e nel frattempo ho sviluppato ottimi rapporti con i service luci di tutti questi paesi, ai quali portavo nuovi apparecchi, nuovi sistemi. Nei primi 10/15 anni della mia carriera, i service luci come li conosciamo oggi non esistevano, a parte qualcuno nel mondo anglosassone. Per questo è completamente naturale per me venire qui a fare degli spettacoli interessanti per artisti con cui non avrei mai avuto contatti se fossi rimasto isolato nel mondo angloamericano.
Come gestisci l’input dell’artista?
Dipende dall’artista. Penso a gente come Mick Jagger, che, quando mi incontrò per la prima volta, 35 anni fa, dopo che mi ebbero presentato con un: “Questo è Patrick, disegnerà le luci; hai delle idee da dargli?”, mi disse: “Molta luce nei primi brani, più oscurità per i ballati” e questo è quanto! Negli anni abbiamo sviluppato un rapporto diverso, c’è molto più interessamento da parte sua. Poi ci sono anche artisti come Phil Collins che ha idee chiarissime su quel che vuole e che con mesi d’anticipo fa sapere in che punto dello show sale sul palco, da dove esce e come tutto debba essere in ogni momento.
Poi ci sono quelli come gli AC/DC, a cui sembra non interessare niente, a parte il fatto fondamentale che vogliono vedere il pubblico...
Abbiamo parlato con Cosmo, lighting director del tuo spettacolo con AC/DC due anni fa, e ci ha detto che l’unico input della band di cui fosse a conoscenza era che volevano tanto calore...
Sì, vogliono sentire quell’energia che adesso con i testamobile non arriva. Ai vecchi tempi con centinaia di PAR da 1000 W si sentiva proprio la luce sul palco. Anche Tina Turner è così, vuole sentire il calore delle luci.
Molto del mio lavoro sta nello sviluppare un rapporto con l’artista e nel capire non come voglia le luci, ma chi sia... spesso l’artista non sa chi è. Pensa di essere una cosa e vuole essere qualcos’altro. Si deve costantemente lavorare a sostenere l’artista: vuole fare il lunatico e il misterioso? Vuole esser amico di tutti? Vuole essere qualche via di mezzo? Per fare questo lavoro uno deve diventare psicologo tanto quanto tecnico o designer.
E quando l’artista decide di cambiare qualcosa?
È una situazione molto delicata, e non perché si scontrino le opinioni di due persone o perché debba prevalere l’opinione di uno piuttosto che quella dell’altro, perché se l’artista vede rosso un pezzo che io vedo blu, non è un grosso problema accontentarlo. La questione è che in questa situazione il mio lavoro è molto “pubblico”. Vedo davvero il risultato del lavoro di tutta la mia squadra solo quando sono in platea ed accendo per la prima volta il palco. E stiamo parlando di sistemi molto costosi: costa migliaia e migliaia di euro al giorno avere la crew a disposizione per farli funzionare... non si può fare su un foglio.
Al primo giorno di prove accendo tutto e sembra bellissimo e tutti non aspettano altro che vederlo funzionare. Dopo qualche giorno di prove e miglioramenti – e direi che questo è successo invariabilmente per ogni grande spettacolo che io abbia mai fatto – gli artisti cominciano a guardare lo spettacolo e dire “beh, è abbastanza bello, ma perché questo pezzettino qui non è di là; o perché hai fatto così; o perché la batteria ha fatto ‘bip’ e le luci poi hanno fatto ‘bap’”. Ci possono essere cento motivi per questo o per quello: l’operatore stava facendo qualcos’altro, il pulsante era programmato in modo sbagliato, stavamo lavorando su un altro brano, abbiamo semplicemente sbagliato... ma non si può passare tutto il tempo in prova dicendo “scusate... scusate...”. Questa è la ragione per cui è importantissimo il rapporto con l’artista e il rapporto con la gente che lo circonda.
Per la parte creativa puoi scegliere qualsiasi soluzione ti sembri opportuna, ma quando si tratta di coordinare una squadra composta di esseri umani, tenere alta l’autostima di tutti, gestire la tecnologia e i rapporti con l’artista, beh, è un lavoro complicato e delicato.
Due parole sul tuo metodo di lavoro?
Si comincia con il set e con la scaletta. Ascolti la musica e guardi il set... tutto vive e tutto muore sul set. Mi ricordo uno spettacolo in Francia, anni fa, con un fondale che sembrava una pelle di dalmata, bianco e nero. Dopo qualche minuto, qualsiasi luce scegliessi, faceva venire il mal di testa. Un disastro.
Ho visto tanti spettacoli dove il primo numero è fantastico e spettacolare, e anche il secondo è fantastico e spettacolare, poi anche il terzo e anche il quarto: a quel punto la spettacolarità non è più spettacolare. È come una cena: cominci con un antipasto fantastico, poi ci vuole qualcosa di delicato, poi un piatto forte, poi del formaggio e il migliore dei dessert per finire. Ecco, questo paragone mi è appena venuto in mente, e forse lo userò ancora! Comunque, molto di questo non ha a che fare con la luce e l’ombra: per questo si deve capire la musica.