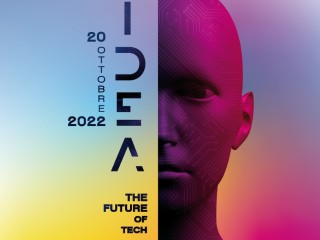Diffusori audio - seconda parte
Un approccio empirico alla progettazione dei sistemi a radiazione diretta, e non. Seconda parte.
 Figura 5: Risposta in frequenza del DUT in cassa chiusa con Vc variabile
Figura 5: Risposta in frequenza del DUT in cassa chiusa con Vc variabile Figura 6: Impedenza del DUT in cassa chiusa con Vc variabile
Figura 6: Impedenza del DUT in cassa chiusa con Vc variabile Figura 7: Risposta in frequenza DUT in cassa chiusa con Qtc variabile
Figura 7: Risposta in frequenza DUT in cassa chiusa con Qtc variabile Figura 8: Impedenza del DUT in cassa chiusa con Qtc variabile
Figura 8: Impedenza del DUT in cassa chiusa con Qtc variabileIn questa rubrica viene affrontato in maniera estremamente semplice, quasi banale, il metodo con cui dimensionare il cabinet di un diffusore acustico a radiazione diretta. Step-by-step vengono ripercorse le fasi che un ipotetico autocostruttore-sperimentatore potrebbe seguire per giungere alla definizione della soluzione ottimale in funzione degli obiettivi.
All’interno della categoria “radiazione diretta” si annoverano differenti possibilità di caricamento: bass reflex, cassa chiusa, infinite baffle, linea di trasmissione, dipolo, linea a quarto d’onda, ecc... Questa serie di articoli ha lo scopo di offrire una riflessione, quanto più imparziale possibile, sui motivi che inducono alla scelta di una particolare topologia rispetto alle altre, tentando di superare i consolidati luoghi comuni che hanno credito nell’ambiente dell’audio. Nel numero scorso sono stati presentati il metodo e l’approccio. Come altoparlante-cavia è stato scelto il Ciare HX205, un modello presente di frequente nei progetti degli autocostruttori; ne sono state analizzate (sommariamente) le caratteristiche costruttive ed i parametri di Thiele e Small (T&S), basandosi sui dati dichiarati e disponibili su web.
Nella prima puntata sono state fatte delle considerazioni sulle due configurazioni più semplici, ovvero altoparlante in aria libera e su baffle infinito. Oltre alla semplicità concettuale queste configurazioni sono importanti perché definiscono quel è il funzionamento “naturale” dell’altoparlante, definendo un benchmark delle prestazioni ottenibili per quanto riguarda linearità ed estensione in frequenza dall’altoparlante in esame. In questa seconda parte – probabilmente la più breve della serie – viene preso in considerazione il caricamento in cassa chiusa, ovvero un’applicazione nella quale l’emissione posteriore del trasduttore viene confinata ad un volume finito.
Cassa chiusa
Volume Vc variabile
Detto-fatto, il nostro costruisce una serie di cabinet perfettamente rigidi, senza perdite e di volume via via decrescente, misurando poi il comportamento del woofer nelle diverse condizioni. Nelle figure 5 e 6 sono riportate la risposta in frequenza ed il modulo dell’impedenza per Vc = {1000, 500, 250, 100, 75, 50, 25, 10, 5, 3, 2, 1} dm3. A volume minore corrisponde una maggiore Fc ed anche una maggiore enfasi nel picco della risposta in frequenza (figura 5).
Una prima osservazione evidenzia che:
- riducendo il volume del box chiuso si viene sempre a perdere estensione in frequenza verso il basso dello spettro;
- le riduzioni di estensione sono più significative per Vc < Vas;
- al diminuire del volume aumenta la frequenza di risonanza Fc e si stringe la campana della curva di impedenza;
- all’aumentare di Vc ci si avvicina alle performance del baffle infinito.
Come già detto, in questa ed in tutte le simulazioni si ipotizza di avere cabinet perfettamente rigidi e privi di perdite. Nulla, se non diversamente specificato, è la presenza di assorbente acustico o altro che possano assorbire energia meccanica (e sonora).
Da un punto di vista prettamente fisico, il volume di carico del DUT, alias l’aria contenuta nel cabinet, è assimilabile ad una molla d’aria, similmente a quanto avviene nello stantuffo di una siringa. Tanto più il volume d’aria all’interno della siringa è piccolo e tanto più sarà “duro” comprimere lo stantuffo.
I volumi d’aria simulati hanno senso? Alcuni sì altri meno; tecnicamente, infatti, non è possibile realizzare un box di un solo litro, ma sarebbe difficile realizzarlo anche di 5 l, capace di contenere l’altoparlante. La simulazione è stata fatta solo per enfatizzare i risultati.
Qtc variabile
Nella pratica, per dimensionare una cassa chiusa si procede solitamente in maniera opposta, ovvero si impone un determinato Qtc, fattore di merito totale del box chiuso, e si calcola conseguentemente il volume necessario ad ottenerlo. Nelle figure 7 e 8 si vedono le risposte per Qtc = {0.44 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2}.


Le curve sono molto simili a quelle delle figure 5 e 6 in quanto il Qtc rappresentato graficamente è stato ottenuto con i seguenti volumi di carico: {∞ 75 27 15.4 10.3 5.7 3.1} dm3.
Il sistema fisico non è cambiato; sono variati solo i volumi di caricamento, ma nella sostanza le curve delle figure citate fanno parte della stessa famiglia.
Nel prossimo numero affronteremo il caricamento bass reflex ed i diversi metodi utilizzabili per il dimensionamento.
Vuoi saperne di più sulle nostre pubblicazioni nel settore dell'audio professionale? CLICCA QUI.
Vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità di settore? ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER.